Non è inappropriato affermare che stiamo per raggiungere la piena possibilità tecnica di combattere il dolore fisico indotto dalla malattia nella quasi totalità dei casi in cui esso si manifesta.
La splendida e densissima formula eschilea pathei mathos, e cioè impara attraverso il dolore, comporta l’idea o l’invito ad elaborare, in questi momenti aspri dell’esistenza in cui l’uomo avverte la tentazione di abbandonarsi unicamente al gemito o al pianto, una diversa strategia.
In modo che si attivino ed agiscano forze profonde dell’anima, i cui itinerari non sono identificabili con quelli che il medico può consigliare di percorrere, ma che non per questo hanno alcuna ragione per essere delegittimati.
Proprio attraverso il dolore vediamo emergere una dimensione fondamentale della nostra cultura: l’irriducibile eccedenza dell’essere umano rispetto alle condizioni sociali e biologiche della sua esistenza.
Il dolore siamo noi
In un momento storico, qual è quello che stiamo attraversando, in cui sembrano trionfare elementi manipolativi e distruttivi del rapporto uomo-natura, il tema del dolore sembra richiamare il senso della nostra responsabilità nei confronti della natura umana prima di tutto, ma anche alla natura che ci circonda.
Parlare di dolore e di morte può essere imbarazzante, specialmente se si pensa ad un dolore senza rimedio ad una morte senza speranza, però non c’è nulla che esprima altrettanto bene la nostra natura finita come il dolore e la morte. Sia sul piano ontologico che sul piano morale l’uomo è anche finitezza, sofferenza, male.
Pensiamo solo alla salute ma non abbiamo sconfitto la sofferenza
Il senso della sofferenza e della morte varia nel tempo.
Nella nostra epoca l’unica prospettiva del dolore che ci viene fornita è quella della sua eliminazione grazie al progresso tecnologico.
Guai ad ammalarsi in un mondo che sembra programmato per la buona salute.
Nei tempi moderni si è assistito e si assiste alla progressiva ascesa della salute tra i valori più alti. Gli uomini del nostro tempo sembrano interessati soltanto alla salute.
Se nella parola latina salus era implicito sia il significato di salute fisica, la salute del corpo, sia il significato di salute dello spirito, ossia la salvezza, oggi i due significati si sono differenziati fino ad una sorta di estraniazione. Tutto ciò è avvenuto a danno della salute dello spirito; se però ci riflettiamo bene ciò rischia di produrre danni per il bene di tutto l’uomo, il quale, per il semplice fatto di pensare soltanto alla salute, non ha certo sconfitto la sofferenza, la malattia e la morte. Tutt’altro. Si ammala, soffre e muore di una malattia e di una morte che sono sempre più spesso senza senso e senza speranza.
Il dolore fa parte della nostra vita anche se lo teniamo nascosto
A differenza di quanto accadeva nelle società del passato, dove il dolore lo si incontrava ogni giorno nel volto del malato e nelle celebrazioni collettive della vita e della morte, oggi è venuta meno la circolarità diretta tra il dolore e la vita. Il dolore è celato o spettacolarizzato.
Il dolore, nonostante i progressi tecnici, risorge costantemente anche all’interno del suo inquadramento tecnico. Col rischio che non resti altro da fare che occultarlo o addirittura rimuoverlo.
Io soffro, ma io sono anche noi
È proprio di fronte ad un essere umano che soffre o che è sul punto di morire che vediamo irrompere con maggiore prepotenza il senso della nostra “umanità”. Sono queste vite immerse nel dolore e nella sofferenza che chiedono disperatamente di essere accettate e, addirittura, di essere amate nella loro debolezza e nella loro alterità di esseri umani.
La tradizione sociale non fornisce più l’individuo di comportamenti comunemente condivisi e, se formule e riti tradizionali sono oggi ancora in uso, molti le trovano ipocrite espressioni della vecchia società: mancano nuovi rituali che riflettano l’attuale standard del sentimento e del comportamento e che possano facilitare il superamento di quelle situazioni emotive critiche che inevitabilmente si manifestano. Nel mondo contemporaneo immagini di morte o di dolore ricorrono frequentemente nei mezzi di comunicazione televisiva, giornalistica ed informatica, in questo senso si può sostenere che la morte sia tornata a far parte della vita quotidiana della maggior parte delle persone. Si tratta tuttavia di una morte “altra” e di un dolore “altro”.
Gli uomini dipendono gli uni dagli altri reciprocamente, per cui possiamo trovare nello stesso uomo sia una dimensione individuale sia una comunitaria. Non è corretto dire che tutto dipende dalla società o dall’individuo, ma l’individuo può affermare il proprio io soltanto se è capace di dire anche “noi”; allo stesso tempo la società non ha consistenza al di fuori degli individui e non può essere considerata un oggetto contrapposto al soggetto.
Nel dolore ti aiuto
Il dolore – fisico o morale – è sempre una situazione di sofferenza umana che costituisce una ragione sufficiente per giustificare o sollecitare l’aiuto altrui. Certe volte, quando il dolore è leggero, ce la possiamo cavare anche da soli, ma il dolore, in quanto segnale biologico di una disfunzione dell’organismo, giustifica di per sé qualche richiesta di aiuto.
In quanto liberalità offerta questa iniziativa di aiuto dipende da qualcosa di definibile come un riconoscimento che lo rende possibile. Il riconoscimento dell’altro presuppone il trascendimento dei propri interessi e l’accettazione di quelli dell’altro. L’altro diventa un alter ipse (Aristotele).
Le esperienze del dolore e della sofferenza, nella loro relativa inevitabilità, lasciano intuire una dimensione propria e vera della vita. Attraverso l’esperienza del dolore si può cioè verificare un risveglio dell’esistenza.
Paola Fabbris
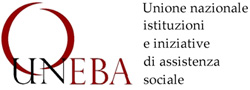













No comment yet, add your voice below!